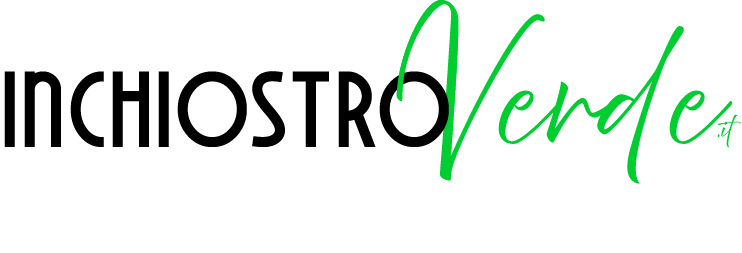Giornata dei martiri meridionali: non si insinui l’humus culturale di guerra civile
TARANTO – L’intervento di Raffaele Nigro dello scorso 9 agosto su “Il Mattino”, nella sua sobrietà apre uno squarcio di luce nella tumultuosa faccenda della celebrazione della giornata della memoria dei martiri meridionali, approvata dalla Regione Puglia il 4 luglio scorso. Da amante della sua terra d’origine, la Basilicata, è stato uno dei primi scrittori e saggisti a riaprire un dibattito nelle vicende post-unitarie, con uno sguardo rivolto al passato.
Basta vedere, per esempio, la cura con cui accompagna il suo libro sul brigantaggio post-unitario, con immagini di manoscritti e fotografie, per individuare la passione nella ricerca, passione critica che ha trasmesso ad un altro studioso, Valentino Romano: è sufficiente un’occhiata alla bibliografia nel sito web “settimanadeibriganti” per comprendere lo sforzo e l’attenzione di chi vuol scavare.
Entrambi non amano particolarmente Garibaldi, ma allo stesso tempo riconoscono che gli eccessi della dinastia borbonica, a cominciare dall’impiccagione o decapitazione (per i nobili ) dei repubblicani del 1799, furono le cause di un odio progressivo verso i regnanti, che soggiaceva in particolare nella media e piccola borghesia come nel mondo intellettuale.
Ma torniamo alla giornata dei martiri. Nell’affrontare lo studio del brigantaggio, non si può omettere ciò che succedeva nella frontiera pontificia anche prima della resa di Gaeta, il 13 febbraio 1861. Ovvero, per esempio, come il generale Lagrange, di padre prussiano e di madre francese, formasse delle truppe volontarie composte anche da briganti, come il famoso Luigi Alonzi, atte a combattere i garibaldini (tra cui anche qualche pugliese) negli Abruzzi.
E ciò fu solo anticipo di ciò che accadde subito dopo il 13 febbraio, il cui giorno come sappiamo è stato scelto dal consiglio regionale pugliese per celebrare la giornata della memoria; ovvero vedremo come un numero crescente di legittimisti europei ed anche semplici avventurieri convergano su Roma, protetti dal governo francese che occupava lo Stato pontificio, l’alleato di sempre dei Borboni.
Il Papa protetto anche all’epoca da miti guardie svizzere esisteva solo in qualche immaginario collettivo. Il governo borbonico ne fece invece grande uso, ed era non solo un corpo numeroso, ma più fedele e più feroce nella repressione, dandone prova soffocando chi difese le prerogative della Costituzione il 15 maggio 1848 a Napoli: un governo che si serve di mercenari stranieri è un governo che teme le sue stesse popolazioni.
Da qui, dal maggio ’48, iniziò il secondo grande errore della dinastia borbonica, l’uso arbitrario della giustizia per condannare, sopprimere, torturare chi osava andargli contro, pur avendo idee morigerate, come Sigismondo Castromediano e Carlo Poerio, umiliare il clero con tendenze pacificamente progressiste, come l’arcivescovo di Lecce monsignor Caputo.
La giustizia come mezzo di repressione era ieri come oggi, un mezzo per attirarsi l’attenzione internazionale. All’epoca, nello specifico, un’ottima scusa per entrare negli affari partenopei da parte dei governi inglese e francese, ma anche suscitando le perplessità dei governi alleati come quello austriaco e in ultimo quello russo, quello stesso governo che non aveva apprezzato lo sterminio dei repubblicani del 1799.
Così due potenze “puntarono” l’Italia meridionale. Gli inglesi consideravano centrale avere un governo amico che scompaginasse l’avanzata dell’impero russo dal mar Nero, mentre Napoleone III, l’imperatore che voleva imitare lo zio e che aveva strozzato la Repubblica Romana del 1849, trafficava sottobanco per sistemare suo cugino Luciano Murat nel regno di Napoli. Operazione, quest’ultima, che magari gli sarebbe riuscita, chissà, se fosse andato ad effetto l’attentato di Agesilao Milano nel 1856 contro Ferdinando II: nello scompiglio generale sarebbero potute intervenire le navi francesi presenti nei dintorni della rada partenopea e quel nutrito gruppo di sostenitori che sempre riempirà pagine di scarni rapporti di polizia (borbonica e sabauda) per circa dieci anni ancora.
Da questo concreto pericolo nasceva nel 1857 la spedizione repubblicana -e con la bandiera dei tre colori- del socialista Carlo Pisacane, soffocata nel sangue dalla popolazione aizzata dal clero reazionario, quella stessa che non contenta della strage (ad iniziare dalle membra disfatte di Ludovico Negroni), pochi giorni dopo prelevò una statua della Madonna -tra lo sbigottimento del parroco- per portarla in processione al fine di ringraziarla per la protezione ricevuta.
Infine il matrimonio per procura dell’erede al trono con la sorella della regina d’Austria, un altro colpo pure all’area moderata di chi pensava ad una Italia confederata, sotto la guida spirituale del Papa, progetto a cui Ferdinando aderì nel 1848 mandando il nostro Guglielmo Pepe a difendere i confini pontifici dagli austriaci nel nord-Italia. Si arrivò dunque all’unità d’Italia sotto la dinastia sabauda, ma potevano succedere cose diverse e peggiori, anche non cambiando niente.
I francesi continueranno ancora per qualche anno a minare l’unità d’Italia, alimentando il brigantaggio meridionale. La semplificazione del brigantaggio come rivolta dei contadini, non è accettabile nella dinamica storica. Se ne è ben reso conto il mio amico Valentino Romano che nel suo testo su Crocco lo definisce piuttosto “filomurattiano”, in contrapposizione al legittimista Borges, invece fedele sino all’ultimo al Borbone. Senza dimenticare che comunque Borges ( che era un comandante straniero ), non aveva con sé le forza distruttrice che ebbe il cardinale Ruffo nel 1799, e che pure i Comitati legittimisti di Roma e di Marsiglia gli avevano promesso.
Ma Crocco era il vero capo delle sue bande ? A leggere le carte processuali lui sostiene di non esserlo stato, che il capo era il francese De Langlais, questione che aveva interessato non poco Giustino Fortunato.
L’oriundo lucano Luigi Settembrini, il 2 marzo 1857, scrisse così al diplomatico inglese Fagan che lo incoraggiava a presentare la domanda di grazia a Ferdinando II°:
“ ….una dimanda di grazia non è un affare personale, non è solamente un sacrifizio della dignità propria e di quel giusto e santo orgoglio che deve avere ogni uomo che si sente uomo, non è un venire a patti come un masnadiere e pregarlo che ti dia la vita; ma è un affare pubblico, è un rinnegare la fede politica che si professa; è un riconoscere per giusto, per legale, per santo un enorme cumulo d’ingiustizie commesse da nove anni …..Se non v’è altra porta per uscir dall’ergastolo, io non picchierò mai a questa: vi resterò, vi morirò, non importa….ma l’onor mio è mio, la mia coscienza è mia, e nessuna potenza al mondo può strapparmi quest’unico bene che mi resta…”
“Scusate le chiacchiere” è il necrologio con cui Settembrini chiese di essere ricordato.
Valerio Lisi, autore del libro “L’Unità e il Meridione. Nicola Mignogna” Lecce, 2011